![]()
E’ scritto nella Bhagavad-gita:
“O migliore dei Bharata, quattro categorie di uomini virtuosi si avvicinano a Me con devozione – gli infelici, coloro che desiderano la ricchezza, i curiosi e coloro che aspirano a conoscere l’Assoluto” (Baghavad-gita, cap. 7, shloka 16).
Eppure io non sono mai riuscita a riconoscermi in nessuna di queste categorie.
Quando incontrai per la prima volta la Gita, non ero né disperata né infelice, d’intelligenza scarsa, con poche aspirazioni e di curiosità media.
Probabilmente appartenevo alla categoria trasversale delle persone un po’ sciocche, senza una vera coscienza di ciò che sono.
Se provavo a descrivermi, infatti, la mia identità mi sfuggiva.
Il mio ruolo sociale, familiare e lavorativo non rifletteva minimamente la mia essenza.
Paradossale – e difficile da spiegare – sentivo di essere me stessa proprio quando “scomparivo”, quando un cordone ombelicale invisibile e mai tagliato all’improvviso mi portava via, in un Mondo Beato e senza confini, quando il Vuoto diventava un Pieno di infinito appagamento, quando nel Nulla scoprivo possibilità sconosciute.
Quando mi regalarono, a diciotto anni, un libro intitolato “La Bhagavad-gita così com’è”, insieme ai primi due canti di un’opera chiamata Srimad Bhagavatam, capii subito che, balzando di mano in mano, quei testi erano partiti da quel mondo per arrivare fino a me.
Inizialmente li collocai tra i libri di avventure. Nel corso degli anni volarono dal reparto di storia a quello di psicologia, dal folklore alla religione, fino a quando decisi che il posto migliore era quello del mio cassetto, dove potevo sfogliarli più rapidamente e comodamente.
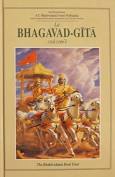
Sul retro della copertina c’era l’immagine di un grande Maestro, sua Divina Grazia A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, con cui avviai da subito un’intensa relazione affettiva. Con lui parlavo, mi confrontavo, discutevo. Quando le cose non andavano per il verso giusto, lo interrogavo e lui mi consigliava, a volte con un sorriso gentile, a volte con un ammonimento, a volte guardandomi accigliato.
Intanto continuavo inutilmente a cercare quel mondo Beato nei libri di psicologia, ma, non trovandolo – se non distorto e nei capitoli dedicati alla psicopatologia – mi guardavo bene dal parlarne in giro, soprattutto con gli autori di quei libri. Per loro, sarei stata solo un esempio clinico.
Durante tutto il mio lungo iter di preparazione universitaria, mentre aumentavano le mie certezze sulla realtà di quel mondo invisibile, diminuivano le mie speranze di trovare nei testi accademici adeguate spiegazioni filosofiche e scientifiche alle mie domande.
Un giorno il cordone ombelicale invisibile diede uno strattone alla vista di un opuscolo pubblicitario di una scuola, il Centro Studi Bhaktivedanta, e questo, oltre a qualche telefonata, mi bastò per decidere di iscrivermi.

Al primo seminario cui partecipai, tra la sorpresa dei suoni celestiali e dei volti sereni intorno a me, mentre osservavo le divinità vestite con straordinaria cura e i quadri con le immagini dei grandi acarya, improvvisamente mi si parò davanti il poster a dimensione umana di Shrila Prabhupada che, col bastone in mano e con atteggiamento di sfida, prima che potessi capacitarmi della sua presenza lì, pareva dirmi: Era ora! Ce ne hai messo di tempo! Sono anni che ti aspetto!
E’ passato tanto tempo da quel momento, e ora ho trovato finalmente i libri di psicologia che parlano di quel mondo glorioso e trascendentale, dei suoi abitanti divini, del Signore dei Tre Mondi e della sua straordinaria compassione verso tutte le creature.
Ho finalmente scoperto la differenza tra identità ed essenza, io e Sé, spirito e natura, atman e coscienza, sogno e visione, e il solo desiderio che mi è rimasto oggi è quello di onorare questa conoscenza confidenziale, questo sapere che è il re di tutte le scienze, il più segreto dei segreti.
Che questa Opera di impareggiabile valore possa trovare un giorno posto nelle scuole e nelle Università, in modo da portare felicità e pace all’umanità intera.
Caterina Carloni

